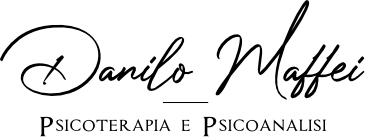Un ponte sospeso
(analisi della dissociazione)
Il ponte non è sostenuto da questa o quella pietra,
ma dalla linea dell’arco che esse formano.
(Italo Calvino)
A questo isolamento siamo sospinti dal nostro sistema del Sè che “per sua natura tende a sfuggire all’influenza di quelle esperienze che non si conciliano con la sua organizzazione e con la sua attività funzionale del momento” (Sullivan, 1953, p. 218). Cerchiamo di dissociare il pensiero e l’emozione connessa, relativi all’esistenza di altre isole, facendo quello che Sullivan chiama operazioni di sicurezza, ovvero attività interpersonali per fuggire o minimizzare l’angoscia.
Durante le nostre prime fasi di vita possiamo vivere la completezza, la condivisione dei nostri opposti, siamo liberi di andare, potenzialmente, in tutte le isole del mare; unirle è facile, non serve ragionamento ma naturalità. Piano piano, succede poi che l’ambiente ci indichi strade percorribili e strade impossibili, così ecco strutturarsi una tripartizione psichica: me buono, me cattivo e non-me (Sullivan, 1940).
“ Il me buono è la personificazione iniziale che organizza quelle esperienze in cui le soddisfazioni dei propri bisogni sono state intensificate da supplementi-premio di tenerezza. Il me cattivo, d’altro lato, è la personificazione iniziale che organizza quelle esperienze nelle quali alle attività che implicano la madre si associa una quantità crescente di angoscia” (Sullivan, 1953, p. 188).
Mentre le prime due personificazioni diventeranno comunicabili per mezzo del linguaggio, il non-me non potrà esserlo; tale tipo di personificazione è tipica dei sogni o di un episodio psicotico grave, si sviluppa gradualmente e rimane a uno stadio primitivo. Essa si compone di aspetti paurosi, orribili e ripugnanti della vita in quanto proviene dall’esperienza di un’angoscia intensa (Thompson, 1964).
Questa categoria di esperienza è alla base dell’ipotesi dei MOID1.
Il trauma psicologico, dunque, avviene in situazioni interpersonali in cui la mancanza di validazione consensuale del Sè non può essere evitata o prevenuta, e non c’è speranza di protezione, sollievo o conforto (Albasi, 1997). Ferenczi afferma che l’angoscia conseguente ad un trauma sia soprattutto dovuta all’incapacità che il bambino prova non potendosi allontanare dalla situazione sofferente né dandosi alla fuga, né allontanando lo stimolo (Ferenczi, 1920-32). Bateson, attraverso il concetto di doppio legame2, sottolinea che si genera psicosi soltanto quando l’individuo non ha alternative allo stare all’interno delle interazioni che disconfermano la sua realtà interna (1972).
Ciò che resta è un’amnesia retroattiva, una memoria somatica priva di oggetti e senza alcuna possibilità di rappresentazione simbolica che non può essere ricordata o raccontata direttamente nel suo significato di umiliazione profonda (Albasi, 1997); si tratta di ciò che D.B. Stern (1997) chiama “esperienze non formulate3”, cioè quel materiale che non è mai entrato a far parte della coscienza.
La relazione è stata causa del trauma e della conseguente dissociazione, e la relazione deve riparare a ciò; c’è bisogno di una nuova storia che ripercorra la vecchia strada fino ad arrivare laddove coesistevano i vari aspetti della personalità, fino a dove, in origine, vi era un unico grande continente. Per far ciò non bisogna utilizzare grandi parole ma uno stare con il paziente, rifare la strada insieme e riviverla emozionalmente. E’ un cammino orizzontale che nel suo procedere va in profondità, acquista una sua verticalità. Ripristinare un significato ontogenetico, ed anche familiare, permette di dare una collocazione agli avvenimenti, di accettare che la ferita inferta era tutto ciò che l’Altro potesse fare in quel momento, di considerare che una ferita inferta è effetto di una ferita subita, di perdonare.
Il senso della storia sta proprio qui. In altre parole, andare a recuperare quelle radici tranciate per vedere se possiamo ripristinare un flusso linfatico transgenerazionale, e, laddove ciò non fosse possibile, saremmo noi, nella stanza di analisi, a dover essere bravi nel creare un innesto che consenta il passaggio. La creazione della nuova storia che viene creata all’interno dell’interazione con l’analista passa attraverso ciò che Gadamer (1960) chiama fusione degli orizzonti4 (Loiacono, 2009), essa permette di affiancare alla storia reale quella simbolica co-costruita nello spazio analitico.
Seguendo il concetto di adattamento simbolico5 di Rank (1924), la formazione dei simboli è il modo più efficace di adattarsi alla realtà: l’uomo si adegua al mondo esterno modificandolo secondo i propri desideri inconsci ( Bonomi, 2004). Rank, seguendo le idee di Ferenczi (1913), affermò che il processo di adattamento simbolico mirasse a restaurare l’equilibrio perduto attraverso la creazione di nuovi simboli. Illusione e disillusione sono le facce della stessa medaglia, la disillusione del Reale ha bisogno dell’illusione del Simbolico. Collegando insieme la soddisfazione perduta e l’attesa nell’appagamento sperato, creando ponti tra il passato e il futuro, i simboli ci permettono di adeguarci al nuovo ambiente senza dover rinunciare alla speranza (Bonomi, 2004).Quando un individuo subisce un trauma, si disgrega, ha letteralmente la sensazione di cadere a pezzi; attraverso il simbolo si cerca di unire ciò che diviene, da questo momento in poi, dissociato, isole fintamente autonome che galleggiano solitarie. Il simbolo collega psiche e soma, quest’ultimo con il mondo esterno; esso costruisce i ponti, rinsalda le arcate, non fa cadere le pietre. Unendo le due isole maggiori, emozione e rappresentazione, si ottiene automaticamente anche il collegamento tra passato e futuro, poiché l’emozione soggiace prevalentemente sotto il livello del mare, appartiene all’inconscio; la rappresentazione ha bisogno dello spazio esterno per dispiegarsi. Ne consegue una comunicazione tra fuori e dentro, tra coscienza e inconscio.
In analisi, la fusione degli orizzonti di analista e analizzando permette la connessione al mondo simbolico attraverso la creazione di significanti della coppia analitica, che non appartiene né al paziente, né tantomeno all’analista. E’ di pertinenza di ciò che Ogden chiama molto acutamente terzo analitico: infatti una ricettività inconscia di questo tipo, associabile allo stato di rêverie (Bion, 1962), implica la parziale consegna della propria individualità separata ad un terzo soggetto generato inconsciamente dalla coppia analitica (Ogden, 1994).
“ Solo nel processo di conclusione dell’analisi, analista e analizzando recuperano le loro menti separate, ma le menti recuperate non sono le stesse di coloro che erano entrati nell’esperienza analitica. Quegli individui non esistono più. L’analista e l’analizzando che si sono ‘recuperati’ come individui separati sono entrambi in modi significativi nuove entità psicologiche che sono state create/trasformate dalla loro esperienza di e dentro il terzo soggetto analitico (il soggetto dell’analisi)” ( Ogden, 1997, p. 11).
Il ponte si collega silenziosamente, le parole scambiate in superficie non permettono di costruire fondamenta solide e neanche arcate in grado di collegarsi tra loro; esso si forma lentamente dentro la pancia, va giù in profondità dove sente l’acqua che scorre nell’immobilità, diviene un tutt’uno con essa fino a quando l’uno non penetra nell’altra e viceversa.
Parole e frasi, come le persone, sono sempre in movimento. Il tentativo di fissare i significati delle parole e delle frasi le trasforma in effigi senza vita, immobili cellule colorate conservate sotto vetro, che solo lontanamente ricordano il tessuto vivente da cui provengono. Quando il linguaggio dell’analista diventa stagnante, non ha più nessuna utilità nel compito di significare l’esperienza umana vitale (Ogden, 1997).
“ Una passeggiata coinvolge l’intera persona;
non è riproducibile;
la sua forma semplicemente accade, si dispiega;
possiede un movimento che è caratteristico di colui che cammina.”
( Ammons, A.R., 1968)6
L’analisi è una forma d’arte che ci chiede non soltanto di affrontare il problema di creare un luogo in cui analista ed analizzando possano vivere, ma anche di sviluppare un uso del linguaggio adeguato a dare voce alla nostra esperienza di cosa significhi essere vivi in quel luogo che continuamente muta. Ci chiediamo, come terzo analitico, di tentare di parlare con la propria voce e con le proprie parole, perché in gran parte è questo che permette all’analisi di essere un evento umano.
Proprio perché la comunicazione si svolge prevalentemente a livello inconscio, non è mai davvero possibile essere sicuri che ciò che è accaduto sia dovuto ai nostri interventi intenzionali o avvenga malgrado questi (Ehrenberg, 1992). Vi sono momenti in cui l’analista e il paziente possono provare delle emozioni che addirittura non appartengono a loro, oppure possono reagire ad un qualche stimolo proveniente dall’altro in modo inconsapevole. Valutare all’interno della relazione analitica il potere della comunicazione inconscia, della comunicazione affettiva, dell’enactment, della bi-direzionalità dell’influenza inconscia; decostruire successivamente queste particolarità interattive implicate, e rendere esplicito ciò che è implicito, non solo sviluppa il dialogo analitico in modo profondo, ma permette di fare una nuova esperienza che sarebbe inimmaginabile altrimenti. Non forniamo la comprensione, non presumiamo di sapere cosa il paziente sente o pensa, piuttosto aiutiamo a chiarire il fatto che non sappiamo né possiamo sapere da soli (Ehrenberg, 1992).
A volte può trattarsi semplicemente di essere in grado di stare insieme in un “silenzio intimo” dove non vi è necessariamente bisogno di parole, e dove colmare gli spazi con le parole, da parte sia del paziente che dell’analista, può essere una difesa del partecipare al momento.
Bromberg ci dice espressamente che “la salute non consiste nell’integrazione. Essa è la capacità di rimanere negli spazi tra realtà diverse senza perderne alcuna” ( Bromberg, 2006, p. 116).
La parola, proprio quella che si attendeva e che si adatta perfettamente al contesto della frase, nel momento in cui giunge può travolgerci con sorpresa, poiché il linguaggio dà corpo, nella voce, a nuove significazioni, quindi a nuove possibilità. Questa parola, attraverso la quale è concepibile un livello del funzionamento della terapia psicoanalitica, nel suo articolarsi, sorge da quello stato di sospensione e di confusione che solitamente sperimentano i poeti. Esso sfiora e porta in parole l’inaccessibile, oltrepassando la sensazione d’intervallo e sospensione tra una parola e l’altra (Giannakoulas,1988).
L’esperienza poetica può essere considerata come un’esperienza creativa paragonabile a quella dimensione del processo terapeutico in cui l’esperienza di realtà e autenticità di se stessi appare intrecciata al sorgere di parole sperimentate come più autentiche. Dove si sperimenta la testimonianza di un’altra persona significativa rispetto alla propria esperienza vissuta, dove si instaura una sorta di sentire fenomenologicamente intenso e diretto a qualcosa di condiviso. Le parole si combinano, descrivendo e producendo una formulazione dell’esperienza che sostanzia l’autenticità e la realtà di se stessi. Il linguaggio, la narrazione, la creatività poetica (attraverso le parole dense di esperienza soggettiva ma condivise intersoggettivamente) può essere un luogo rilevante attraverso il quale le cose si possono formulare in un modo che ci permetta un particolare accesso alla conoscenza ed uno speciale sentimento di essa (Stern, D.B., 2003).
Come per la creazione poetica, molte delle più importanti esperienze formulate durante un processo psicoterapeutico devono essere attese, dobbiamo dare la possibilità a ciascuna di esse di collocarsi dentro il proprio spazio; il che equivale a dire che ci sono fasi in cui, tanto per il clinico quanto per il paziente, non è opportuno porre domande dirette o pretendere una risposta immediata ad esse, così come non lo sarebbe non solo per un poeta rispetto al suo processo creativo, ma nemmeno per un bambino per il farsi di un suo gioco (l’area transizionale7, parafrasando Winnicott 1971, non può essere tradotta se non tradendola, in quanto si regge sul paradosso).
Paul Valery ci illumina in tal senso: “Noi possiamo agire solo entro la libertà dei processi della mente. Noi possiamo diminuire il grado di questa libertà, ma per il resto possiamo semplicemente aspettare, questo è tutto quello che dobbiamo fare” ( Valery8, 1952, cit. in Stern D.B., 2003, p.71).
Il linguaggio creativo non è servile nei confronti degli adattamenti di convenienza. Pur provenendo da un soggetto, ha la capacità di portarlo altrove, di scioglierlo dalle maglie della scontata “ubbidienza familiare”, dai “legami di lealtà” patologici. Questo significa che la parola creativa provoca momenti di disagio, sia perché richiede di sostenere l’inquietudine di ciò che si attua nel suo dirsi, sia perché si scosta dai confortevoli luoghi comuni (Albasi, 1997).
Nello spazio potenziale infinito della scienza si aprono sempre vie alternative da esplorare, nuovissime o antichissime, modi e forme varie, apparenze e oggettività che possono profondamente modificare le nostre fantasie e la realtà, influire sulla nostra creatività e alterare l’immagine del sé individuale e collettivo, come la qualità e perfino la continuità del nostro essere.
Come è stato già osservato in un precedente capitolo di questo lavoro, oggi ogni ramo della scienza sembra ci voglia dimostrare che il mondo si regge su entità sottilissime come i quark, i messaggi del DNA, gli impulsi dei neuroni e quelli determinanti nello spazio dell’individuo fin dall’inizio della sua vita e dal suo concepimento. Privato del proprio inconscio, senza un’anima, senza esperienza e senza un Sé personale e immaginativo, l’Edipo della neuroscienza non cerca più se stesso e chi l’ha portato al mondo (Giannakoulas, 1992). Eppure i poeti ci insegnano che è dall’incontro dell’uomo con se stesso e con gli altri significativi che scaturiscono, attraverso i secoli, le forze più fertili ed immaginative della nostra cultura e, come si sa, sono stati i poeti stessi e gli artisti a infondere alle passioni e alle vicissitudini dell’individuo la dimensione umana dello psichico e del tragico.
Riferendosi all’origine dell’opera d’arte, Heidegger9 (1889-1976) nota: «Con il termine “origine” intendiamo ciò da cui e attraverso cui qualcosa è ciò che è, e il modo in cui lo è. […] L’origine di qualcosa è la fonte della sua natura. Solitamente l’opera emerge da e attraverso l’attività dell’artista. L’artista è l’origine dell’opera. L’opera è l’origine dell’artista. Nessuno è qualcosa senza l’altro» (Heidegger, M., 1933, p.87) .
Attraverso l’atteggiamento poetico ci si confronta, dicendo altro, costruendo altre vie, … la creatività fluendo, ridona tono, stile e singolarità alla vita. La psicoanalisi incontra la poesia perché è un dispositivo per la funzione narrativa considerata come un processo di invenzione piuttosto che di scoperta: non c’è una realtà più vera, ma ci sono molti racconti che, a partire dalla relazione e con essa, possono orientarci in risposta al nostro sentire autentico.
C’è una bellissima poesia di un poeta greco, Kostantinos Kavafis10, che metaforicamente riferiva come Itaca ed il viaggio simboleggiassero il cammino analitico del paziente e dell’analista.
Questa struggente poesia sul senso della vita, ove chiaramente il riferimento mitologico è al celeberrimo viaggio di Ulisse nell’Odissea, diviene metafora di un viaggio verso una meta che si raggiungerà dopo lunghe peregrinazioni. Il poeta afferma qui che non bisogna avere fretta di giungere a destinazione, alla propria Itaca, ma bisogna approfittare del viaggio (e quindi della vita, e dell’analisi?) per esplorare il mondo, crescere intellettualmente e ampliare il proprio patrimonio di conoscenze.
In ultima analisi ( mi si perdoni il gioco di parole) il senso di Itaca è proprio quello di fungere da stimolo per il viaggio più che da meta da raggiungere fine a se stessa. “Itaca” è un viaggio nel quale non è importante se la meta è poi deludente. È giusto apprendere il più possibile durante il percorso, vivere esperienze, tenendo sempre presente il sentimento forte e deciso che porterà a destinazione.
E se poi Itaca sarà peggio di quanto ci si aspettava, valeva la pena raggiungerla per tutto ciò che si è vissuto per arrivarci.
Così recita:
Itaca di Konstantinos Kavafis
Quando ti metterai in viaggio per Itaca
devi augurarti che la strada sia lunga,
fertile in avventure e in esperienze.
I Lestrigoni e i Ciclopi
o la furia di Nettuno non temere,
non sara` questo il genere di incontri
se il pensiero resta alto e un sentimento
fermo guida il tuo spirito e il tuo corpo.
In Ciclopi e Lestrigoni, no certo,
ne’ nell’irato Nettuno incapperai
se non li porti dentro,
se l’anima non te li mette contro.
Devi augurarti che la strada sia lunga.
Che i mattini d’estate siano tanti
quando nei porti – finalmente e con che gioia –
toccherai terra tu per la prima volta:
negli empori fenici indugia e acquista
madreperle coralli ebano e ambre
tutta merce fina, anche profumi
penetranti d’ogni sorta; piu’ profumi inebrianti che puoi,
va in molte citta` egizie
impara una quantità di cose dai dotti.
Sempre devi avere in mente Itaca –
raggiungerla sia il pensiero costante.
Soprattutto, non affrettare il viaggio;
fa che duri a lungo, per anni, e che da vecchio
metta piede sull’isola, tu, ricco
dei tesori accumulati per strada
senza aspettarti ricchezze da Itaca.
Itaca ti ha dato il bel viaggio,
senza di lei mai ti saresti messo
sulla strada: che cos’altro ti aspetti?
E se la trovi povera, non per questo Itaca ti avrà deluso.
Fatto ormai savio, con tutta la tua esperienza addosso
gia` tu avrai capito cio` che Itaca vuole significare.
Kavafis in maniera magistrale ci indica il cammino, ce lo fa assaporare, ci distrae dal pensiero della meta. “Devi augurarti che la strada sia lunga” significa che alla meta si deve arrivare più tardi possibile, poiché di mete certe ve n’è una sola, e non è piacevole, specialmente in quei cuori ( la maggior parte!) ove l’accettazione di essa non è ancora giunta. La consapevolezza che il viaggio rappresenti il vero obiettivo ci fa intendere che il fine del lavoro analitico, poi, non sia l’unione delle sponde per poter vivere saldamente e lungamente sulla terraferma, bensì l’andar per mare tra terre (parti di Sè) che si possono lambire e vivere. Tutto ciò deve avvenire con calma, assaporando e inebriandosi di ogni cosa.
La costruzione del ponte non ha come meta il collegamento tra le isole, quanto il permetterci di andare a viverle. Le pietre, le arcate ed il ponte intero divengono metafora proprio nel loro simboleggiare lo stare in mezzo al mare, alla deriva, nel continuo viaggio dinamico dell’esistenza, trascinati dalle nostre correnti interne. Spesso il paziente sogna di avere la possibilità di vivere con la possibilità di far esperienza di nuove terre, non vuole evitare il contatto con l’acqua ma ha bisogno di una guida che le possa permettere, barcollando ed aggrappandosi, (Bromberg, 2011) di vivere con aspetti di Sè sepolti e dimenticati. La concretizzazione del ponte permette di andare comodamente in ogni dove ma con il rischio di sopraelevarsi, di sopra-vivere. Si toccano terre ma non si vivono emozionalmente poiché quest’ultime rimangono a pelo d’acqua, ove è inaccessibile la profondità della vita intesa sia come passato che come significanti che emergono dalla nostra pancia (Lacan,1974).
Nella relazione terapeutica tutto ciò accade metaforicamente, legando atemporalmente significati che incontriamo lungo il percorso, facendo andare la nostra mente portata dalla corrente della relazione. E’ l’esperienza di abitare un tempo non ciclico e non oggettivato, il kairos, che può permettere di stabilire una differenziazione e un’integrazione tra un prima e un dopo delle nostre narrazioni biografiche (Albasi, 1997) . Regolandosi solo sul tempo dell’orologio (chronos) si perderebbe l’esperienza atemporale, che è quella che permette di creare nuovi significati. La compenetrazione dei tempi, potenzialmente presente in ciascun passo della vita quotidiana, si mostra solo se la memoria è una presenza viva, solo così essa può essere reinventata e nuovamente scritta creativamente per essere reale. La realtà, per essere un’esperienza soggettivamente significativa, deve diventare sia qualcosa che scopriamo sia qualcosa che inventiamo (Winnicott, 1971).
L’importanza della condizione di avere un testimone, reale e che dia significato di realtà all’esperienza, per la possibilità di queste trasformazioni soggettivamente significative delle memorie traumatiche, è molto importante. Riconoscere delle parti di sé, attraverso la relazione con l’altro, è specificatamente il presupposto per la creazione di interlocutori interiorizzati, di testimoni; sentendosi e vedendosi come se non si fosse isolati, pur stando soli, si possono riconoscere, come proprie, alcune parti dell’esperienza. Allo stesso modo, il terapeuta può ascoltare i pazienti come se fossero loro stessi ad ascoltarsi. A partire da questo ascolto, si possono creare metafore quali integrazioni tra passato e presente (Stern, 2003).
Essere i testimoni di un paziente traumatizzato significa convalidare emotivamente l’accettazione di avere effettivamente perso la possibilità di essere riconosciuti, la speranza di essere visti e sentiti attraverso l’altro. Ciò si traduce nel pensare: “Io sarò con te in tutto il processo in cui tu affronterai la mia perdita. Io sono il tuo testimone” (Laub 1991, p. 89).
In questo modo tra presente e passato potranno ricostruirsi dei ponti, dei nessi narrativi.
Aprendo una breccia nella dissociazione, il trauma può essere sognato e raccontato, e, parte di questo può ritornare al kairos, liberando l’interscambio di significati attraverso il tempo. Nello “scongelamento” di alcuni ricordi, attraverso la possibilità di raccontarli ad un testimone, si vanno a recuperare anche alcuni aspetti di quella parte di se stessi che ha preceduto il trauma e si ricrea una coesistenza. La narrazione che collega (integra e supera la dissociazione) parti di sé attraverso il tempo (kairos), conforta perché è attivata da un accurato processo di formulazione, ascoltato da un interlocutore responsivo, da una presenza che in certi casi dice di un’assenza.
Non è la narrazione di per se stessa, né la formulazione linguistica a livello esplicito e dichiarativo di un racconto che hanno valore trasformativo ed evolutivo, perché non è un meccanismo intrapsichico di generazione di parole lo scenario reale e il contesto di questo complesso processo di cambiamento; quel contesto è la soggettività di due persone profondamente coinvolte nel cercare la realtà e il senso di una esperienza di vita (o dell’esperienza di una vita), persone che hanno a disposizione la loro mente, mente che ha a disposizione il potente strumento del coinvolgimento ….. malgrado noi stessi… ( Giannakoulas, 1988).
Questa esperienza interpersonale è ciò che Ogden intende con il concetto di “essere alla deriva” ( Ogden, 1997, p. 86) quando spiega l’uso della rêverie nella situazione analitica; una riflessione che egli ci porta a fare è inerente alla retrospettività come meccanismo di riconoscimento della forza e direzione della corrente.
La rêverie è al tempo stesso un evento personale e intersoggettivo, in genere l’analista non comunica direttamente al paziente le proprie esperienze, tenta piuttosto di parlargli a partire da ciò che pensa e sente; ossia, tenta di trarre ciò che dice dalla consapevolezza della propria esperienza emotiva con il paziente (Ogden, 1997). Paradossalmente, essa non è una creazione esclusiva ma bensì il prodotto del succitato “terzo analitico” (Ogden, 1994).
Il paziente sogna il desiderio di riconnettersi a parti di sé dimenticate, sente che la sua isola è diventata troppo piccola, il terreno sul quale è costruita la sua casa è instabile. L’analista, nello stesso momento pensa alla sua relazione, alla sua verità … creare dei ponti sospesi che permettano il collegamento tra le varie sponde del Sè. All’inizio della propria carriera professionale, esso è convinto che il ponte debba sopraelevare l’acqua; successivamente, con l’esperienza , si rende conto che ciò taglia fuori la parte emozionale, per evitarlo bisogna stare a contatto con l’acqua, direttamente sull’abisso del blu. Egli si convince che il percorso debba avvenire sull’acqua, bisogna rischiare di sentirsi alla deriva. La coppia analitica deve imparare a nuotare, solamente ciò può permetterle di scegliere su quale sponda appoggiarsi e quando. Quando la corrente è forte, lasciarsi trasportare per vedere dove essa ci porta, nei momenti di quiete invece, avere la libertà di scegliere quale direzione prendere attraverso il proprio desiderio e non per il bisogno di stare aggrappati per non saper nuotare.
Si noti che in questa rotazione, in questo cambia-mento, il ponte sospeso diviene metafora contraria del suo reale significato: esso diviene punto di congiunzione tra passato e presente, la corrente ci fa capire che esiste nella nostra vita un filo rosso che unisce ciò che è stato con quello che è, e che sarà. Il ponte sospeso deve percorrere l’acqua, non elevarsi ad essa, deve permettere al paziente di divenire sospeso dal proprio giudizio e non oltrepassare le emozioni.
E’ solamente attraverso la sospensione del giudizio e l’individuazione (imparare a nuotare con le proprie forze) che possiamo lambire ed attraccare in porti di isole che pensavamo perdute.
Parlare della rêverie in analisi è tremendamente difficile, essa scivola inavvertitamente in altri stati psichici. Non ha un chiaro punto di partenza o di conclusione che la separi, per esempio, da un pensiero del processo secondario che la segue o la precede (Bion, 1962). Essa solo raramente è traducibile in maniera puntuale in una comprensione di ciò che sta accadendo nella relazione analitica. Il tentativo di fare un uso interpretativo immediato del contenuto ideativo o affettivo delle rêverie dell’analista porta solitamente a interpretazioni superficiali nelle quali il contenuto manifesto viene trattato come se fosse intercambiabile con il contenuto latente; infatti è difficile usarle come fossero sogni poiché al contrario di essi, l’esperienza non avviene in un arco temporale delimitato (tra il momento in cui ci addormentiamo e quello in cui ci svegliamo).
Questa via potrebbe condurre, o almeno così pare, ad un altro “regno”. Quel regno nascosto che si costituisce, che nasce, si produce, solo nel momento della relazione. Non se ne ha sentore all’inizio, e non sempre si manifesta. I segni che l’annunciano giungono all’improvviso, inaspettati. Arrivano senza chiasso, senza clamore. Giungono e basta. Una volta manifestati modificano l’atmosfera della stanza dove sta avvenendo l’incontro con l’altro, con la diversità (Focchi, 2006).
L’approssimarci all’Altro implica un atto volontario, una nostra determinazione che non darebbe i frutti sperati se non tentassimo in tutti i modi di preservare la differenza; se si tentasse di possedere l’Altro evitando, invece, di lasciarsi guidare dalle correnti mosse dall’emergere di tali segni.
Ma non basta. Non basta preservare la differenza, non basta annullare la tentazione di impossessarci del dato: dobbiamo non aver paura di perderci, di affogare (Levinas, 1978).
Anzi, dobbiamo mostrarci pronti al fatto di non aver nulla da dire, di rimanere soli, senza strumenti, senza mezzi. Solo aprendoci alla possibilità che l’Altro veda in noi non una guida sicura, ma un compagno di viaggio, potremo riuscire ad incontrarlo veramente. Solo inoltrandoci in questi sentieri, sulle vie appena accennate, noi possiamo, infine, sentirci alla deriva, abbandonando ogni pretesa di immediata intelligibilità e disponendoci alla possibilità di “smarrirci” percorrendo quelle acque sconosciute; di avventurarci in quel territorio che ci è concesso di percorrere.
In questa operazione di autentica rinuncia ad appropriarsi dell’Altro la ragione non aiuta. Anzi, a volte, è d’impaccio. Nel momento in cui ci accorgiamo del mostrarsi di questi segni, la peggior cosa che possiamo fare è chiederne conto all’altro, o a noi stessi. Essi non vanno pensati, solo seguiti, aprendosi la strada a fatica. Così facendo, ci pervade la sensazione che, in tali momenti, si possa arrivare più vicini all’autentica comprensione (Rovatti, 1995).
La cosa difficile è cercare di spiegare a chi non è mai stato in una relazione terapeutica, quali siano questi segni, queste tracce e come si manifestino. La sola cosa che si possa dire è che tali segni, spesso, si mostrano in un momento di silenzio. Momento nel quale la parola, che pure mantiene un posto privilegiato nella terapia, si ritrae, subisce uno scacco, si perde, facendo emergere un’altra psicologia . Non vi sono due soggettività, ma l’una e l’altra si fondono (Ogden, 1994), come membri di quel determinato rapporto, solo a partire dal dialogo interiore, dall’intersoggettività.
1 Cfr. Albasi, C. (2007). Attaccamenti traumatici. I modelli operativi interni dissociati. Torino:UTETConcetto ripreso da quello di Modello Operativo Interno (MOI), proposto da Bowlby (1973) come un’alternativa ai concetti psicoanalitici relativi alle strutture mentali che si formano sulla base delle relazioni interpersonali. I MOImsono memorie delle relazioni che acquisiscono un valore strutturale per la mente. Infatti, in una prospettiva relazionale, la mente sviluppa le sue strutture e i suoi processi funzionali all’interno delle relazioni di attaccamento. Le esperienze delle relazioni di attaccamento, dunque, non vengono semplicemente ricordate ma offrono anche le regole per organizzare i ricordi e i contenuti dell’esperienza. La mente, a differenza di quanto suggeriva la prospettiva pulsionale della psicoanalisi freudiana, costruisce le regole del suo funzionamento durante lo sviluppo, nel rapporto e nel contatto con le altre persone.
2 Il doppio legame (detto anche doppio vincolo, in originale: double bind) è un concetto psicologico elaborato dall’antropologo e pensatore Gregory Bateson, e utilizzato in seguito da altri membri della cosiddetta scuola di Palo Alto.Esso indica una situazione in cui la comunicazione tra individui uniti da una relazione emotivamente rilevante, presenta una incongruenza tra il livello del discorso esplicito (verbale, quel che vien detto) e un altro
livello, detto metacomunicativo (non verbale, gesti, atteggiamenti, tono di voce), e la situazione sia tale per cui il ricevente del messaggio non abbia la possibilità di decidere quale dei due livelli ritenere valido (visto che si contraddicono) e nemmeno di far notare l’incongruenza a livello esplicito.
Voce URL in Wikipedia, ed. italiana.
3 Cfr. Stern, D.B. (1997). L’esperienza non formulata. Dalla dissociazione all’immaginazione in psicoanalisi. Pisa:Edizioni Del Cerro (2007).
4 Il fine dell’interpretazione è per Gadamer la “fusione degli orizzonti” tra testo e interprete: solo l’unificazione tra i due permette la comprensione. Ciò è possibile perché i due orizzonti appartengono alla stessa storia. Proprio perché il soggetto del sapere è sempre storico, il suo rapporto con il passato non può che assumere la forma di un’integrazione, di una fusione di orizzonti. Il carattere aperto dell’interpretazione risiede proprio nel fatto che l’integrazione a cui essa mira non è messa a disposizione dell’oggetto, ma una fusione di orizzonti, da intendersi come circolo ermeneutico e dialogo tra l’interprete e il suo oggetto, proprio perché la comprensione opera una fusione in forme “sempre nuove e vitali”, in una dialettica continua di domanda e risposta. La fusione è “quel cerchio che abbraccia e comprende tutto ciò che è visibile da un certo punto” e quindi non è mai completa identità senza alterità, in Cfr. Gadamer, H. (1960). Verità e metodo. Milano: Bompiani (2001).
5 Cfr. Rank, O. (1924). Il trauma della nascita. Milano: Sugarco editore (1990).
6Cfr. Ammons, A.R. (1968). A poem is a walk, in Epoch, 28, p.114.
7 L’ipotesi originale sui concetti di oggetto transizionale e fenomeno transizionale è stata presentata da Winnicott nel 1951. L’autore sostiene come sia nota a tutti la varietà di modi in cui i bambini utilizzano il loro primo oggetto posseduto come “non-me”, intorno all’età di 6-12 mesi. La sequenza di eventi hanno inizio con la suzione del pollice (propria del neonato) per progredire verso l’attaccamento ad un orsacchiotto o ad un giocattolo. Tali fenomeni rappresentano qualcosa di più del semplice eccitamento o soddisfazione orale: danno inizio ad un rapporto oggettuale affettuoso, che sviluppa nel bambino la capacità di pensare, inventare e produrre l’oggetto. I fenomeni transizionali si collocano altresì in un’area intermedia di esperienza, a cui contribuiscono la vita interna e il mondo esterno. Gli oggetti e i fenomeni transizionali sono utili, in quanto caratterizzano una fase in cui il bambino fa entrare oggetti diversi-da-sé nel modello personale. Ciò significa che stanno per il seno e promuovono l’attività del fantasticare e del pensare un’esperienza illusoria.L’importanza dell’oggetto transizionale è data dal suo non essere seno (o madre), per quanto sia reale, ma stare per il seno (o per la madre). Esso permette il passaggio dal Principio di piacere al Principdi realtà ; in Cfr. Winnicott D.W. (1953). Oggetti transizionali e fenomeni transizionali, In Gioco e realtà. Roma: Armando editore, 1974.
8 Ambroise Paul Toussaint Jules Valéry (Sète, 30 ottobre 1871– Parigi, 20 luglio 1945), scrittore e poeta francese.
Voce URL in Wikipedia, ed. italiana.
9 Cfr. Heidegger, M. (1933). L’origine dell’opera d’arte. Milano: Marinotti editore, 2000.
10 Konstantinos Petrou Kavafis, (Alessandria d’Egitto, 29 aprile 1863 – Alessandria d’Egitto, 29 aprile 1933), è stato un poeta e giornalista greco. Kavafis era uno scettico che fu accusato di attaccare i tradizionali valori della cristianità, del patriottismo, e dell’eterosessualità, anche se non sempre si trovò a suo agio nel ruolo di anticonformista.Pubblicò 154 poesie, ma molte altre sono rimaste incomplete o allo stato di bozza. Scrisse le sue poesie più importanti dopo i quarant’anni. Voce URL in Wikipedia, ed. italiana.